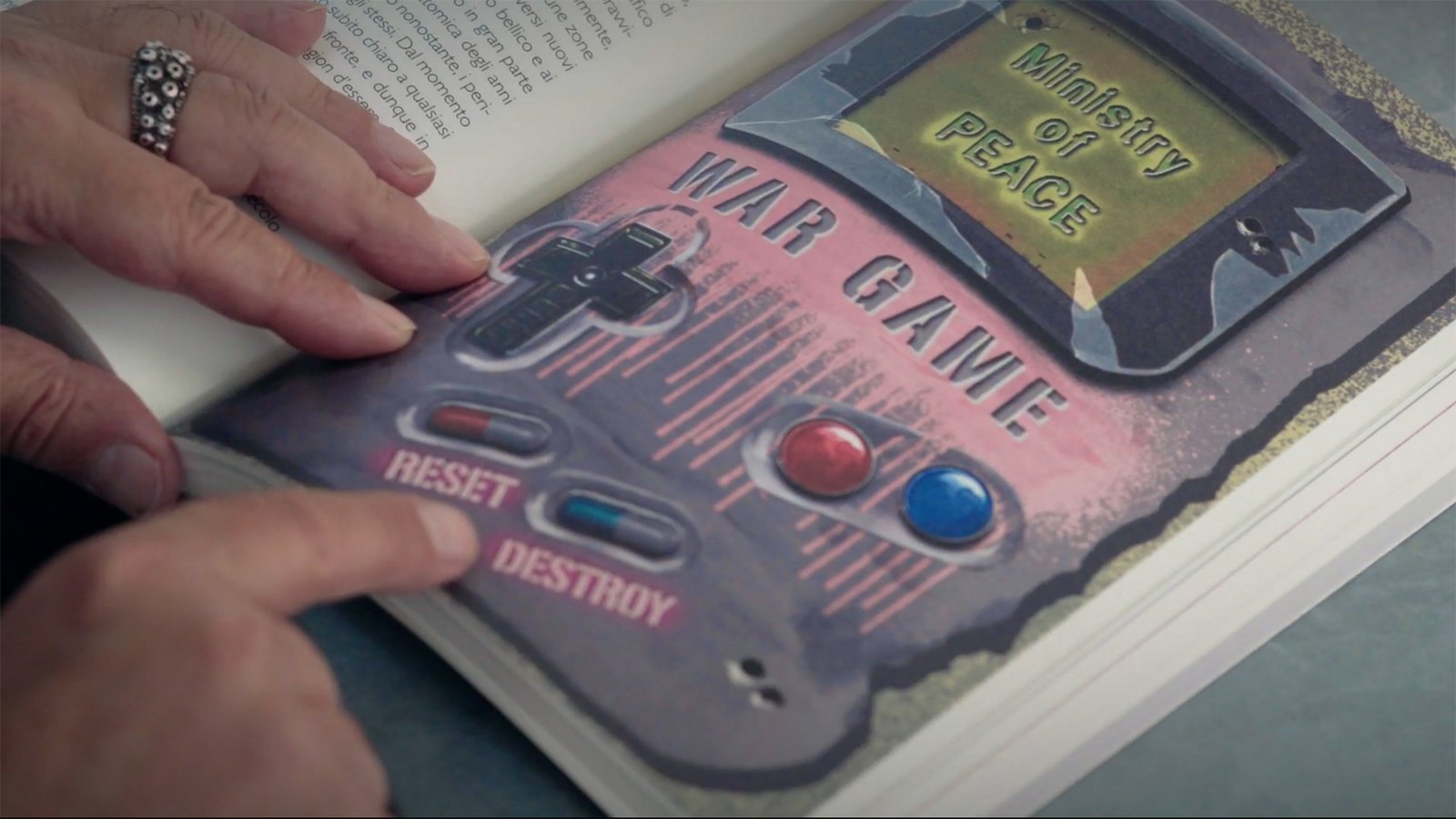La grammatica dello sguardo: come le Immagini influenzano la percezione
Un viaggio nell'educazione visiva nell'era digitale. Un'analisi dell'arte e della comunicazione contemporanea
L’intera civiltà si è sviluppata, almeno negli ultimi due millenni, intorno a una matrice squisitamente verbale: la parola è da sempre il veicolo primario di logica, poesia, racconto, legge, epica e predicazione religiosa. Ovviamente le immagini non sono mai state estranee alla storia dell’umanità – dalle pitture rupestri a Giotto, dai codici miniati alle serigrafie di Warhol –, ma le parole hanno sempre preservato la loro aura di superiorità epistemologica, quasi fossero l’unico “segno” a poterci offrire l’autentica chiave di interpretazione del mondo.
Con l’avvento della rivoluzione digitale, però, qualcosa ha iniziato a incrinarsi. Oggi assistiamo a un surplus di immagini così devastante, così invasivo, così clamorosamente istantaneo, da far vacillare le nostre più profonde certezze linguistiche. È come se un’improvvisa cascata di stimoli visivi stesse sommergendo quelle convenzioni concettuali che ci avevano rassicurato per secoli. Beninteso, non è che la società sia diventata improvvisamente allergica al testo: i social sono ancora pieni zeppi di parole, argomentazioni, riflessioni, commenti chilometrici. Il punto, semmai, è che le piattaforme digitali stanno plasmando un ecosistema in cui l’impatto visivo possiede un predominio a dir poco inedito, capace di collocare la maggior parte della nostra esperienza online in un vertiginoso spazio di “visualizzazione integrale”.
 Ritratto ufficiale del presidente americano Donald J. Trump
Ritratto ufficiale del presidente americano Donald J. Trump
Si potrebbe pensare che questa rivoluzione visiva fosse di per sé inevitabile. L’interfaccia delle piattaforme sembra intrinsecamente programmata per trasformare l’immagine in moneta di scambio globale. Ma a guardarla in controluce, aldilà del perimetro degli “schermi”, questa tendenza non è affatto scontata: la storia ci ricorda che l’Occidente, quantomeno, ha sempre subordinato la forza evocativa dell’immagine a quella più nobile del logos. Platone la definiva “copia della copia dell’idea”, gettando le basi di un sospetto plurisecolare verso il “visivo”: l’immagine inganna, seduce, illude. La filosofia e l’ermeneutica hanno coltivato l’idea che ciò che conta per la vera conoscenza sia la parola, in quanto razionale e analitica, mentre l’immagine va sempre sottoposta a una solida interpretazione critica, se non direttamente disciplinata con rigore.
La grammatica dei social network, al contrario, ribalta – o quantomeno rimodula – il granitico primato del testo: la scrittura diventa spesso una didascalia, un’appendice utile ma secondaria, talvolta accessoria, qualcosa che arricchisce o specifica l’immagine, ma non il perno su cui ruota tutta la comunicazione. E questo, a mio avviso, è una diretta conseguenza dell’incredibile velocità con cui oggi scambiamo informazioni, input, stimoli. La parola, per sua natura, richiede tempo per essere letta, interpretata, talvolta contestualizzata; l’immagine colpisce e invade la retina con immediatezza, senza bisogno di alfabetizzazioni particolarmente complesse. Il problema sta tutto lì: senza una reale educazione all’immagine, le persone – gli utenti – finiscono col “parlare” un linguaggio articolato senza capire davvero quel che dicono e, soprattutto, ciò che viene detto loro.
 Vic Vicente, Bambina con Occhiali VR
Vic Vicente, Bambina con Occhiali VR
Ora, una delle ragioni dell’ascesa delle immagini è senza dubbio la nostra atavica pigrizia mentale. È più comodo assorbire un messaggio istantaneo che mettersi a decodificare lunghi periodi ipotetici o complesse argomentazioni filosofiche. In una società dove il tempo – o la percezione che ne abbiamo – sembra costantemente in deficit, l’immagine è il “segno” (semioticamente parlando) perfetto per trasmettere informazioni in modo quasi istantaneo. A costo, questo mi sembra evidente, di bypassare quella zona del cervello deputata alla riflessione critica. Non tanto perché le immagini non possano stimolarla, tutt’altro, ma perché siamo disabituati a farlo. Aggiungo un dettaglio: parole e stimoli visivi, almeno sui social, agiscono quasi sempre in sinergia, modellando la percezione del messaggio sul piano emotivo e cognitivo. Ripeto: la lingua scritta non è sul punto di estinguersi, ma si sta adattando a un nuovo spazio iper-mediatizzato, dove il testo diventa sempre più veloce, frammentato, ibrido, incastonato in un flusso di immagini che catturano l’attenzione e la “dirottano” su di sé. Per quanto ci concentriamo sulle parole presenti in un contenuto, le immagini che lo accompagnano intessono un dialogo interiore – spesso molto più rapido e incisivo – con la nostra mente, sfruttando tutti i bias del caso. La parola rimane, certo, ma viene messa a margine, costretta a farsi didascalia, a “spiegare” un’immagine la cui potenza iconica non ha bisogno di troppe giustificazioni.
Ci troviamo quindi di fronte a una nuova forma alfabetizzazione, una “visual literacy” che andrebbe coltivata, proprio come abbiamo fatto nei secoli col linguaggio scritto. Dovremmo considerare l’educazione all’immagine – la capacità di leggere, interpretare, criticare e persino creare contenuti visivi – come parte integrante dei programmi scolastici. L’insegnamento della lingua, della letteratura, della grammatica e della sintassi è (giustamente) la colonna portante di ogni sistema educativo. Su questo non si discute: è impossibile comprendere la realtà e interagirvi in maniera complessa se non si padroneggiano gli strumenti della lingua. Ma la “grammatica” visiva ha sempre più bisogno di essere analizzata, compresa e studiata con un approccio serio e condiviso. Siamo letteralmente sommersi dalle immagini: se non impariamo a “leggerle” (e dunque smontarle, confrontarle, metterle in discussione), rischiamo di abitare un mondo che parla un linguaggio di cui ignoriamo le regole di base.
 Frida Kahlo / La vita di un'icona all'ArtScience Museum di Marina Bay Sands.
Frida Kahlo / La vita di un'icona all'ArtScience Museum di Marina Bay Sands.
Lo sforzo richiesto non si esaurisce nei confini della didattica: partendo dal presupposto che la rivoluzione visuale non può più essere arginata, tutti dovremmo imparare a muoverci agilmente in un mondo, di fatto, inedito. E il primo passo è sviluppare consapevolezza critica; banale a dirsi, forse, ma difficilissimo a farsi: l’obiettivo è smettere di essere fruitori passivi e diventare spettatori vigili, che si interrogano sui contesti in cui le immagini emergono, su chi le ha generate, su quali interessi possano celarsi dietro un determinato tipo di rappresentazione. In secondo luogo, bisognerebbe riconoscere una dignità autentica al linguaggio dell’immagine, al pari del linguaggio scritto.
Siamo sempre in tempo per dedicarci a uno studio formale della comunicazione visuale, con un approccio strutturato, analitico, che ci insegni a scomporre un frame, a interpretare un testo visivo, a leggere una fotografia con la stessa cura che abbiamo imparato ad accordare alla produzione letteraria. È un lavoro lungo, che implica un profondo cambiamento di mentalità. Ma proprio in virtù dell’influenza che le immagini esercitano sulla nostra psiche e sulla nostra percezione della realtà, non possiamo più rimandarlo. Terza cosa: i social network non vanno demonizzati, ma compresi. La vita si è già ibridata col digitale – la dicotomia virtuale-reale è già stata ampiamente superata. Occorre comprendere cha dimensione online non definisce sé stessa all’interno di un mondo parallelo, ma sviluppa un’estensione (talvolta distorta, questo non lo metto in dubbio) del mondo reale, e come tale va trattata.
 Zach Blas, The Objectivist Drug Party
Zach Blas, The Objectivist Drug Party
Il futuro – e qui sta la punta di ottimismo che voglio concedermi – potrebbe essere quello di una società capace di integrare testo e immagine, parola e visione, logica e intuizione, riflessione analitica e immediatezza comunicativa. L’essere umano è un animale profondamente simbolico: si nutre di storie, di metafore, di concetti astratti, ma anche di segni e icone concreti. Siamo solo all’inizio di un processo che non possiamo più ignorare: la cultura dell’immagine, smaterializzata e ubiqua, apre possibilità inedite ma richiede, al contempo, una presa di responsabilità individuale e collettiva. È una “nuova alfabetizzazione” che non possiamo più sottrarci dal vivere, pena un’ignoranza più sottile e pervasiva di quanto possiamo ancora misurare. Forse non sappiamo ancora dove ci porterà, ma di certo sappiamo che ci troviamo in viaggio; tanto vale, allora, dotarci di una bussola – e quella bussola, oggi, è la maturazione di un “occhio” critico.
Troppo idealista? Forse, ma la creatività e la consapevolezza talvolta germogliano proprio dove sembravano impossibili. E chissà che il bombardamento di immagini non ci costringa, prima o poi, a rallentare, a scegliere quelle a cui prestare vera attenzione, a riappropriarci del silenzio, della noia e della contemplazione. In mezzo al flusso incessante di pixel potremmo scoprire un nuovo modo di essere umani, più consapevole, meno intransigente, e finalmente aperto all’idea che anche le immagini, se lette con gli strumenti opportuni, possano raccontare e farci comprendere il mondo con la stessa ricchezza della parola.
Immagine di copertina: Universe of Water Particles on a Rock where People Gather, teamLab Planets Tokyo by Note Tanum
Creativo, docente ed esperto di cultura visiva, Alessandro Carnevale lavora in TV da diversi anni e ha esposto le sue opere in tutto il mondo. Nel 2020, la Business School de Il Sole 24 Ore lo ha inserito tra i cinque migliori content creator italiani in campo artistico: sui social media si occupa di divulgazione culturale, coprendo un ampio spettro di discipline, tra cui la psicologia della percezione, la semiotica visiva, la filosofia estetica e l'arte contemporanea. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, pubblicato saggi e scritto una serie di graphic novel insieme al fisico teorico Davide De Biasio; è direttore artistico di un museo all'aperto. Oggi, come consulente, lavora nel mondo della comunicazione, della formazione e dell'educazione.