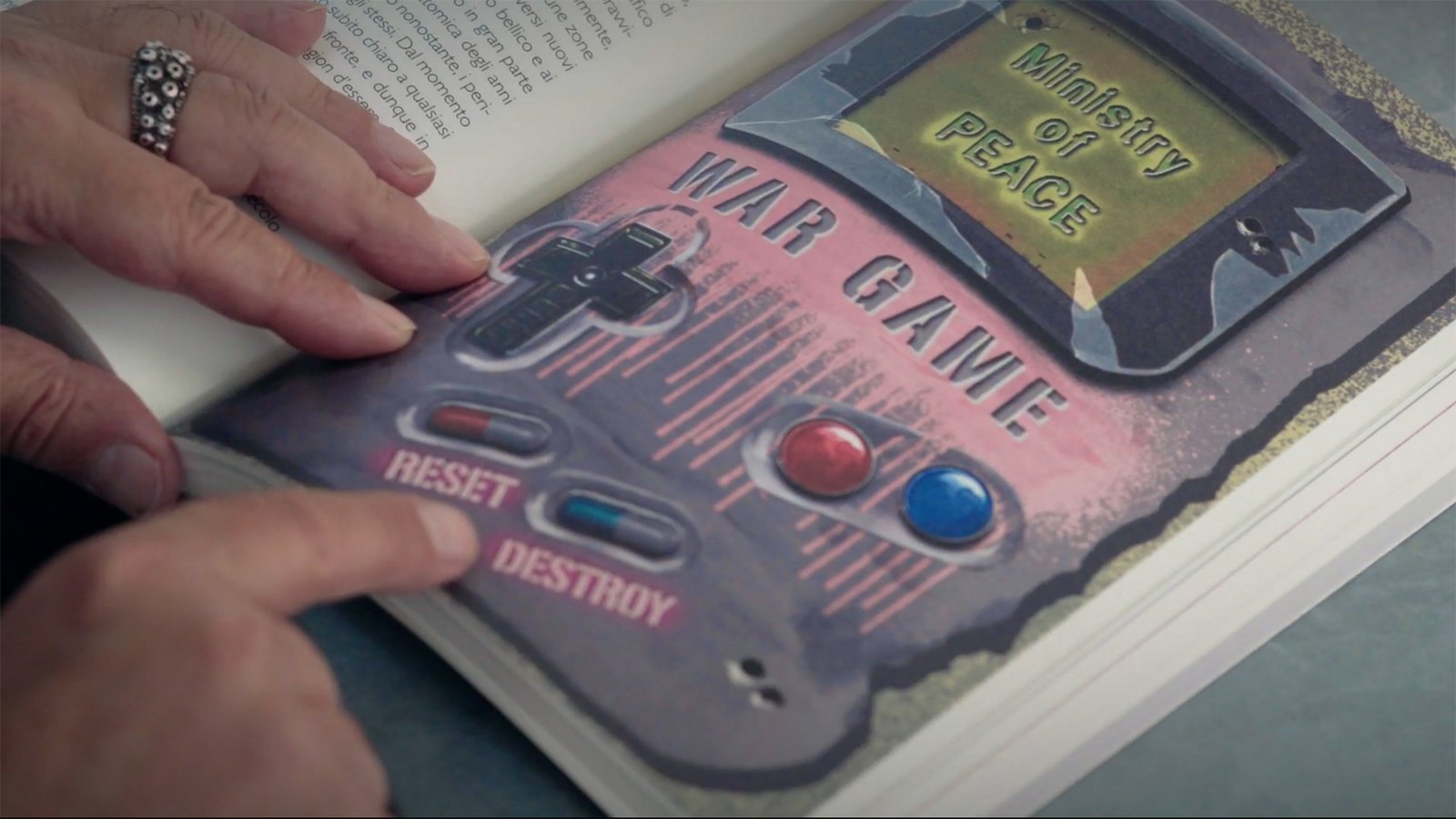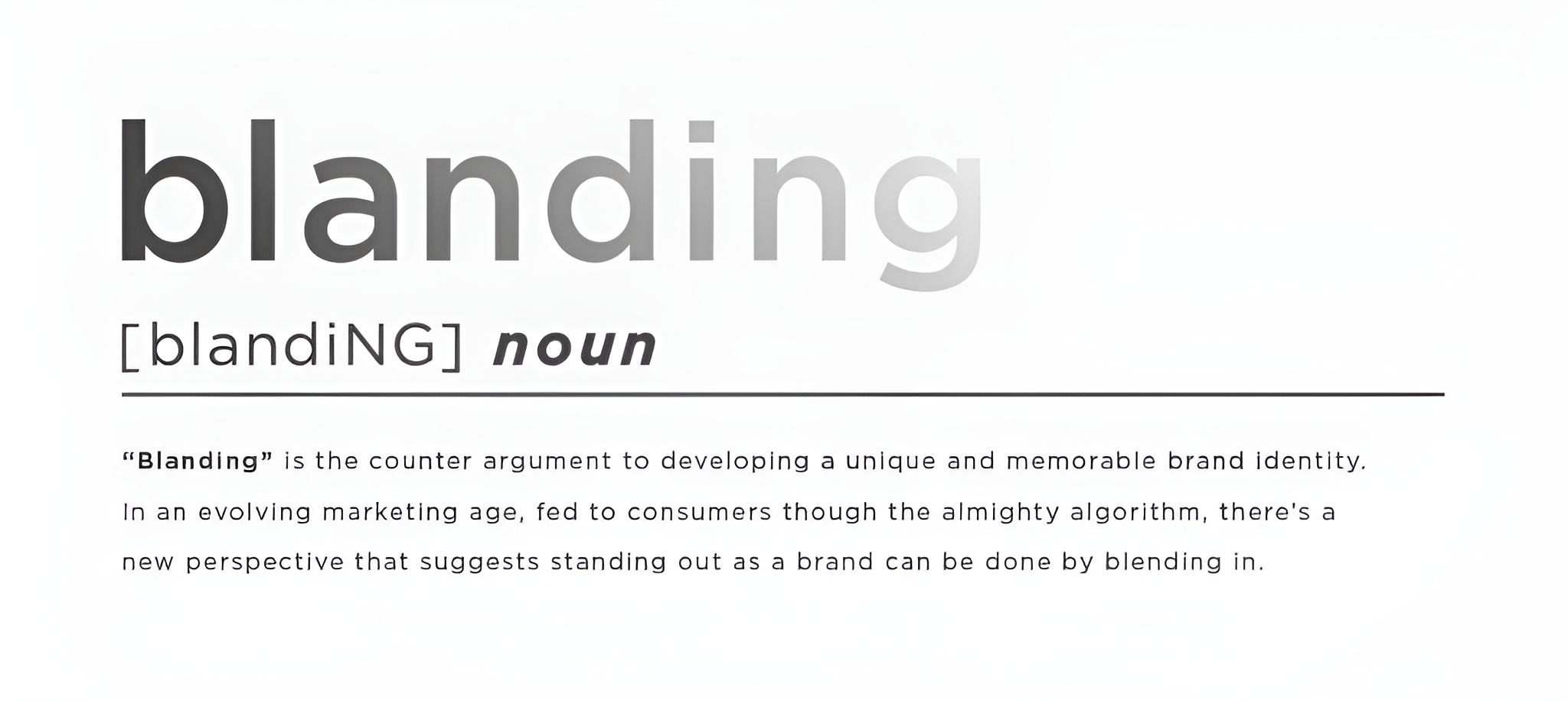
Il “Blanding” nel mondo dell’arte: quando i loghi culturali perdono identità
Perché i loghi delle istituzioni culturali sembrano tutti uguali?
Scorrendo il feed di Instagram, ultimamente, mi sembra di trovarmi in un enorme déjà-vu. Leggo notizie di eventi, talk, mostre e non ricordo l’autore della pubblicazione o non riesco subito a risalire alla fonte. Stanchezza? Può darsi. Distrazione? Sicuramente. Ma noto che c’è dell’altro, una sensazione di straniamento e confusione: sono l’unica a vedere foto profilo di istituzioni culturali tutte uguali?
Apro la lista dei contatti seguiti ed ecco la conferma: una carrellata di loghi di musei, fondazioni, magazine solo impercettibilmente diversi tra loro. Come è possibile navigare in questo mare di barche tutte identiche? Dove è finita la specificità di un luogo? Dove sono i simboli che trasmettono e identificano la mission di un museo? Dove è finita l’unicità che fa la differenza?
Decido così di uscire da questo labirinto di pensieri chiedendo a dei professionisti il loro punto di vista: Beatrice, freelance Graphic Designer; Filippo, Graphic Designer e Art Director; Daniele, Digital Strategist e Giorgio, Art Director e Graphic Designer.
La domanda di partenza è stata per tutti la stessa, ovvero: “I loghi delle istituzioni culturali, soprattutto sui profili social, negli ultimi anni sembrano tutti uguali: scritte nere lineari su sfondi bianchi, in alcuni casi scritte bianche su sfondo nero, ma sempre con la stessa impostazione visiva. Questa è solo una mia impressione o, invece, ci sono delle “regole del gioco” precise alla base di questa tendenza?”
Immediatamente Beatrice mi suggerisce di cercare il fenomeno del Blanding, una tendenza nata circa nel 2018 inizialmente nell’ambito moda, caratterizzata dalla sostituzione dei loghi più comuni e storici delle maison con caratteri sans-serif e “dalla riduzione dell’identità in cambio di un aspetto che ne limita la distinzione dai concorrenti” (Fontanesi, Lampoon magazine, 2023). Le motivazioni reali dietro a questo fenomeno non sono del tutto chiare e interessano questioni come il valore percepito della marca e quello intrinseco dei prodotti, il distacco da uno stile associato a epoche storiche cariche di valori a oggi discutibili, la fluidità del mondo contemporaneo alle prese con molteplici e diversi mezzi di comunicazione, il puro e semplice marketing.
Filippo mi rassicura dicendomi che non è affatto una tendenza casuale, quella notata. “La somiglianza tra i loghi delle istituzioni culturali, soprattutto musei, fondazioni e centri d’arte, risponde a logiche precise, legate a una visione ben definita del ruolo della comunicazione visiva nel mondo della cultura. L’identità di questi enti si costruisce su un linguaggio visivo sobrio, spesso monocromatico, ed è una scelta che punta alla chiarezza, alla neutralità, all’autorevolezza. Le radici arrivano dal design svizzero. Ma il maestro Massimo Vignelli ha insegnato bene come farlo. I loghi delle istituzioni sono una forma di comunicazione che rifiuta l’ornamento e preferisce la misura, proprio perché il contenuto di un'istituzione nella moda, nell’arte o nella cultura in generale dà spazio più all’immagine di un quadro o a una campagna fotografica. La comunicazione visiva e grafica fa da cornice, in maniera ben studiata ma modesta. A differenza di un brand commerciale, un museo non deve sedurre né invadere lo spazio visivo dello spettatore. Deve piuttosto costruire fiducia, farsi riconoscere come luogo di pensiero, di accesso libero alla cultura. E, paradossalmente, più si toglie, più si rafforza il messaggio. Per questo l’adozione di un’identità visiva minimalista è oggi (come ieri...) una scelta tanto diffusa quanto, a mio avviso, delicata. Non è infatti un linguaggio per tutti, sia da digerire che da gestire. Gestire con intelligenza un’identità visiva così ridotta all’essenziale richiede sensibilità, ma il minimalismo, quando è ben fatto, accompagna. Ed è proprio lì che funziona”.
Daniele mi dà una risposta molto simile accennando a un ritorno alla tipografia e all’attenzione a concetti di visibilità/ accessibilità che si esprime con contrasti importanti, scritte chiare, font leggibili. E aggiunge “sui social oramai non è tanto il logo ma il contenuto che incide sulla percezione”.
La risposta di Giorgio è molto simile: “Io trovo che i loghi abbiano un ruolo ormai ancillare nella comunicazione, e non ne siano il centro da un bel po'. L'esposizione del marchio non è più dirimente, e la parte mnemonica spesso passa per l'architettura dell'immaginario, che però deve essere molto più dinamico e mutevole. Se un marchio ha forme estremamente caratterizzate è difficile accostare nuovi immaginari. Se è molto neutro, questa cosa è decisamente meno impattante. Non sono sicuro sia una tendenza durevole, ma anche i colori di brand sono sempre meno importanti”.
 Blanding, Source: IG @giuliana_matarrese
Blanding, Source: IG @giuliana_matarrese
Anche Beatrice, dopo la dritta sul Blandig, si accoda a questo discorso, ma aggiunge altri due aspetti da considerare: la lettura dei loghi sui device digitali, che “vengono compressi meglio se più minimal, neutri e meno dettagliati di quelli curvilinei” e il fatto che le istituzioni culturali non vogliano sembrare “brand commerciali”. Quindi “il logo diventa un elemento che lascia spazio al contenuto culturale — mostre, eventi, opere. È una scelta ideologica: “noi non siamo il messaggio, lo veicoliamo”.
Le domande nella mia testa aumentano sempre di più. Parole come posizionamento e differenziazione si fanno sempre più offuscate, inconsistenti. Ma soprattutto: se il marchio è diventato marginale, la comunicazione della mission, a questo punto, deve essere fortissima se intende costruire un immaginario resistente e persistente nella dinamicità contemporanea senza supporti grafico simbolici né cromatici. Questo significa, forse, che la comunicazione coordinata si fa solo per contenuti? E come si distinguono questi contenuti se non ho riferimenti specifici, o se quelli che ho evolvono in fretta? Come fa dunque un fruitore, visitatore, curioso, studioso, a ri-conoscere un luogo a lui caro anche nella giungla virtuale? Le immagini non sono più persistenti delle parole?
“È proprio quello il punto! Questo appiattimento visivo, anche se nasce da scelte “studiate” alla fine rischia davvero di essere controproducente. Cioè se nel feed ti confondi tra un museo e un altro, forse qualcosa non sta funzionando. È paradossale perché nel tentativo di sembrare “seri” e non troppo brandizzate molte istituzioni finiscono per assomigliarsi tutte. E se sparisci nel mare bianco e nero, che senso ha avere un’identità visiva? Credo che non serva per forza essere eccentrici o urlare, ma un minimo di riconoscibilità — soprattutto oggi — è fondamentale” afferma Beatrice che da anni porta avanti questa “lotta” nei suoi progetti.
Giorgio, invece, mi riporta alla realtà con una risposta che mi arriva diretta come uno schiaffo in faccia: “Il fatto è che di uno spazio riconoscibile non ne hai estremamente bisogno: una volta la call to action era un concetto gassoso, quindi arredavi la comunicazione come un luogo che doveva essere riconoscibile. Tu facevi un investimento in pubblicità, ma non sapevi quale fosse l'impatto realistico di una campagna, anche perché la sua misurazione era complessa e si faceva a campione. Speravi che un tizio uscisse di casa, andasse al negozio di elettrodomestici e si comprasse un frullatore perché lo aveva visto su una pubblicità pagata a caro prezzo. Avevi molte difficoltà: la disponibilità del prodotto, i consigli del venditore, il prezzo incerto, la memoria del cliente... Ora la call to action è precisa: clicca qui! Sempre disponibile il pezzo. Sempre misurabile l'efficacia, sempre migliorabile il funnel... che te ne fai di mission, vision e art direction? Alle aziende la comunicazione serve a vendere”.
SBAM!
Ecco la frase magica, quella che mi fa capire che il Blanding non è solo un fenomeno legato alla moda, ma trasversale, che interessa tutto e tutti. In un articolo del 2023 dal titolo “Cos’è il blanding e perché i brand sembrano tutti uguali?” (letmetell.it) si parlava di una precisa direzione visiva “attuata da aziende che hanno progettato i loro prodotti idealmente già posizionati sulla grid di Instagram o sul feed di TikTok e di design molto simili tra loro perché rivolti soprattutto alla Gen Z, ovvero il 40% dei consumatori”, quindi facilmente leggibili dai più comuni siti di e-commerce.
Il vaso di Pandora è stato aperto. Lo sconforto dilaga. I numeri hanno vinto ancora una volta sulla poesia.
Immagine di copertina: Blanding definition, by Grin
Gaia Badioni (1986) muove i suoi primi passi nel settore dell’arte lavorando per un decennio all’interno di prestigiose istituzioni milanesi dedicate al contemporaneo - tra le quali Pirelli HangarBicocca e Fondazione Prada - ricoprendo per esse diversi ruoli.
Da sempre abituata a osservare, ascoltare, sentire e vivere l' Arte in tutte le sue forme, decide poi di raccontare mediante la scrittura le sue esperienze affiancando al lavoro museale, a partire dal 2013, quello di contributor per diverse riviste di settore come Inside Art, Telescope di Lara Facco, Rivista Studio, the Walkman Magazine, D’Ars Magazine, Juliet Art Magazine, attività che mantiene viva ancora oggi.
La sua formazione è continua. Tra le esperienze più significative si citano il corso “Literary Social Media Content Creator per i musei d’arte contemporanea” al Castello di Rivoli a cura di Gianluigi Ricuperati; “September Book”, workshop di editoria d’arte presso Fondazione ICA di Milano; “Fare Arte”, residenza presso La Scuola di Palazzo Te (Mantova), con Stefano Arienti, Mariangela Gualtieri e Stefano Baia Curioni. È attualmente laureanda in Editoria e Comunicazione Visiva e Digitale presso l’Università degli studi di Bergamo.