
Brain Rot: una diagnosi culturale
“Brain Rot” non è solo una parola. In primo luogo perché le parole sono due, e quindi sarebbe meglio parlare di locuzione, ma soprattutto perché “cervello marcio” è diventata l’impietosa ed efficacissima etichetta culturale del 2024.
Eletta parola dell’anno dalla Oxford University Press, editrice dell’Oxford English Dictionary, la “marcescenza del cervello” evoca un’inquietante immagine organica che rappresenta – cito testualmente – il “presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, considerato soprattutto come risultato di un consumo eccessivo di materiale (attualmente in particolare di contenuti online) ritenuto banale o poco stimolante”.
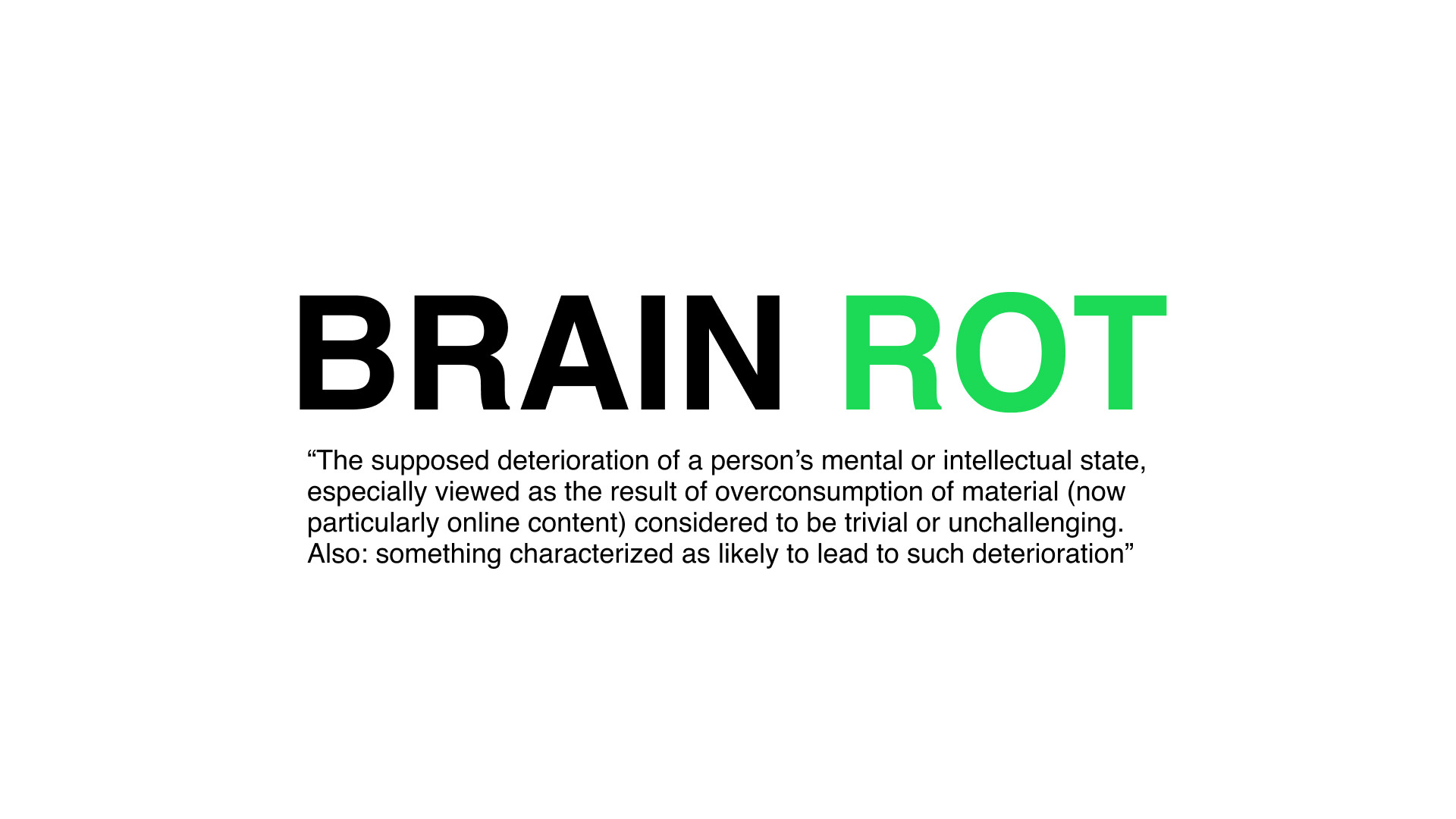
Brain Rot è, a conti fatti, il nome di una malattia (auto)diagnosticata di cui nessuno pensa di soffrire in prima persona. Siamo tutti abilissimi nel riconoscerne i sintomi, a patto che si manifestino negli “altri”: abbassamento della soglia dell’attenzione, fruizione compulsiva di Shorts, Stories e Reel, perdita della concezione del tempo trascorso sui social. Sappiamo che il problema esiste (perché esiste, eccome), però non ci riguarda. Non in modo così drammatico, almeno. O forse sì?
Facciamo un passo indietro: dove nasce il termine “Brain Rot”? La parola, di per sé, esiste da qualche secolo, ma su internet la locuzione ha assunto un significato relativamente inedito. Fin dai primi mesi del 2024, nello specifico, l’hashtag #brainrot è stato condiviso su Tik Tok migliaia di volte, fino a diventare virale. Nei video che hanno lanciato il trend si vedevano ragazzi e ragazze, spesso giovanissimi, che raccontavano di aver sperimentato dei comportamenti anomali (talvolta tragicomici) dopo aver passato ore a “scrollare” contenuti sulla piattaforma: c’è chi confessava di aver scambiato il telecomando per lo smartphone, chi cercava – con un gesto automatico – di interagire con un oggetto inanimato come fosse uno display touchscreen. L’hashtag ha ben presto superato i confini di Tik Tok, per “contagiare” (interessante notare che la terminologia internettiana sia così affine a quella medica) altre piattaforme, fino a esser notata dall’Oxford Press, che l’ha inserita nella rosa dei termini candidati a rappresentare l’anno che, mentre scrivo, sta ormai per concludersi.
La crescente consapevolezza dei rischi e delle dinamiche “tossiche” generate dal consumo ossessivo di video brevi (o brevissimi) che caratterizzano il panorama contenutistico dei vari Social, ha fatto sì che la parola Brain Rot diventasse una vera e propria “istantanea” del 2024: la locuzione nasce scherzosamente su internet, quindi, ma riesce ad assorbire un portato culturale più ampio – e in qualche misura, perfino scientifico – che l’ha resa degna (anzi, degnissima) di essere eletta “parola dell’anno”. Ecco, proviamo un attimo a capire cosa c’è di concreto, da un punto di vista psicologico e neuroscientifico, in quest’iperbole visiva del cervello in marcescenza.
Quando guardiamo un Reel, uno Shorts o un Tik Took, nel nostro cervello si attiva un complesso sistema di gratificazione che sfrutta una delle reti neurali più antiche della mente umana: il circuito della ricompensa. Il sistema, che in ottica evolutiva ha sempre avuto un ruolo cruciale per la sopravvivenza della nostra specie, include strutture come il nucleo accumbens, l’area tegmentale ventrale e la corteccia prefrontale, ed è responsabile della nostra capacità di cercare, ottenere e provare piacere da ciò che ci “gratifica”. Lo scopo intrinseco del circuito cerebrale è quello di aumentare la percezione positiva dopo aver svolto attività essenziali come trovare cibo, costruire relazioni sociali o ottenere successo in compiti che possiamo genericamente definire “vitali”. Oggi, però, i contenuti online sfruttano il sistema in modi che il nostro cervello, evolutivamente parlando, non è preparato a gestire.
 Circuito dopaminergico
Circuito dopaminergico
Semplificando un po’ la questione, possiamo dire che ogni volta che un video riesce a intrattenerci, il nostro nucleo accumbens rilascia dopamina, il neurotrasmettitore che regola il piacere e la motivazione. La dopamina, in termini comportamentali, serve per rinforzare il valore dell’azione che l’ha prodotta, spingendoci attivamente a voler ripetere l’esperienza. Durante la fruizione passiva di video brevi, questa dinamica è amplificata dalla loro struttura: iniziano con un gancio visivo efficace che cattura immediatamente l’attenzione; si sviluppano in pochi secondi, risolvendo un’emozione o una curiosità in modo rapido e intrigante; infine, appena terminano, ci lasciano pronti a passare al contenuto successivo con un semplice movimento del dito. Un meccanismo così coinvolgente finisce col creare un ciclo continuo di gratificazione immediata, in cui ogni video produce una piccola dose di dopamina che ci tiene – letteralmente – agganciati alla piattaforma.
 Formula dopamina
Formula dopamina
C’è un altro aspetto da tenere a mente: non è soltanto il piacere momentaneo a rendere i contenuti così accattivanti, ma anche (anzi, soprattutto) l’anticipazione di quello che verrà dopo. Avete presente lo spot del Campari con il belloccio in abito vittoriano che chiede “e se l’attesa del piacere fosse essa stessa il piacere?” Ecco, il principio è quello. Ogni volta che scorriamo verso il prossimo video, il nostro cervello entra in uno stato di “attesa attiva” in cui si prepara a ricevere una nuova ricompensa: il semplice atto di scrollare è già di per sé piacevole, poiché alimenta la curiosità e stimola il circuito della ricompensa.
Non solo: chi mastica un po’ di psicologia avrà già intravisto un collegamento con il concetto di “rinforzo intermittente” studiato da B.F. Skinner nei suoi esperimenti sul condizionamento operante. In buona sostanza, le ricompense non prevedibili, cioè quelle che arrivano a intervalli relativamente casuali, sono molto più efficaci nel creare dipendenza rispetto a quelle costanti. Pensate a una sessione di scrolling sui social: è ovvio che non tutti i video siano incredibilmente divertenti o stimolanti, eppure la possibilità che il prossimo video sia "quello giusto" ci spinge a continuare a scorrere. Poi, ogni tanto, un video particolarmente appagante premia il nostro sforzo, rinforzando il comportamento.
 B.F. Skinner
B.F. Skinner
Un meccanismo quasi identico, per capirci, viene utilizzato nelle slot machine, dove la prospettiva della vittoria tiene i giocatori incollati per ore e ore (svuotando, com’è tristemente noto, le loro tasche). Nei social media, lo scrolling diventa una forma di "gioco d'azzardo mentale", dove la ricompensa arriva sotto forma di intrattenimento, emozione o curiosità soddisfatta. Questo velato collegamento con la ludopatia ci porta a discutere dei lati decisamente più oscuri della dinamica cognitivo-comportamentale legata alla fruizione compulsiva di contenuti digitali. Lo scrolling perpetuo induce il cervello a sviluppare una vera e propria forma di tolleranza, nota come downregulation dopaminica. A forza di ricevere micro-ricompense rapide e frequenti, i recettori della dopamina diventano meno sensibili: tradotto, abbiamo bisogno di stimoli sempre più intensi per provare lo stesso piacere che sperimentavamo inizialmente. Ciò spiega – parzialmente e contestualmente – perché le attività che richiedono più tempo e impegno, come leggere un libro, guardare un film o contemplare un’opera d’arte, tendono a sembrare meno gratificanti rispetto al consumo di video brevi. Il nostro cervello, letteralmente, si sta abituando a un livello di stimolazione così elevato che tutto il resto, in confronto, appare noioso.
Il fenomeno della tolleranza possiede anche un impatto diretto sulla nostra capacità di provare soddisfazione duratura. Come accennavo, ogni ciclo di scrolling diventa meno appagante del precedente, generando una forma di insoddisfazione cronica: anche laddove ci imbattiamo in un contenuto piacevole, la sensazione positiva risulta quasi sempre insoddisfacente, proprio perché il cervello si è già preparato a ricevere lo stimolo successivo. È una condizione molto simile a quella sperimentata nelle dipendenze da sostanze, dove la tolleranza al principio psicotropo spinge l’individuo a esporsi progressivamente a dosi maggiori per riempire un vuoto che sembra crescere sempre di più. Ovviamente la fruizione compulsiva di contenuti digitali non è paragonabile, in termini di compromissione psicofisica – e per fortuna, direi – a una dipendenza da alcol, droga o gioco d’azzardo, ma la sensazione descritta dal termine Brain Rot è un effetto collaterale concreto e tangibile di una dinamica relativamente inedita.

La stanchezza mentale che accompagna una lunga sessione di scrolling, dunque, è il risultato di un pesante sovraccarico cognitivo e sensoriale. Ogni contenuto digitale richiede al cervello di processare stimoli visivi, uditivi ed emotivi in rapida successione, consumando enormi quantità di energia cognitiva. A differenza di attività più lente e focalizzate, come leggere, disegnare o scrivere, la fruizione di video brevi stimola continui cambi di attenzione, oltre a una rapida elaborazione delle informazioni: dopo un certo periodo, il nostro cervello si “satura”, causando una sensazione di vuoto e stanchezza, malgrado il corpo fisicamente non abbia compiuto alcuno sforzo.
Nondimeno, la natura iper-stimolante dei contenuti digitali frammentati inibisce il rilassamento delle reti neurali di default, le stesse che si attivano durante momenti di calma o introspezione. Parliamo di circuiti cruciali per il recupero mentale, poiché permettono al cervello di riorganizzarsi e consolidare le informazioni. Se il cervello non ha mai il tempo di "staccare", però, il risultato è una stanchezza simile a quella che si prova dopo una giornata di lavoro intenso, priva però del naturale senso di appagamento che accompagna gli sforzi che generano un risultato tangibile. Suona un po’ neomarxista, ma il Brain Rot è, a conti fatti, una forma contemporanea di alienazione.
Come se ne esce, quindi? Non è così facile. E non basta dire: cancellatevi dai social. Perché se è vero che la maggior parte dei contenuti online sono una specie di droga digitale, non possiamo negare il fatto che esistano anche dei contenuti preziosissimi, in grado di arricchire la nostra visione del mondo con prospettive inedite, originali e interessanti. L’unica soluzione, a mio avviso, è quella di lavorare per “sottrazione”. Eliminare il superfluo, limitare lo scrolling fine a sé stesso, individuare poche fonti interessanti (o cercarle, certo, ma in modo più attivo e consapevole) e investire energia nella fruizione di contenuti di qualità. Sforzandoci di approfondire, soprattutto. Perché i migliori Shorts, Reel e Tik Tok servono a questo: a instillare una scintilla di curiosità. La cosa peggiore che possiamo fare, rapportandoci a questi contenuti invitanti e seducenti, è pensare che siano in grado di “risolvere” davvero l’argomento che affrontano (e sto già parlando di contenuti informativi, divulgativi o artistici di valore). Prendiamoli per quello che sono: piccole cartoline di infiniti universi da esplorare. Prendiamoli per un “invito”, però, e non come una visita guidata all-inclusive.
Allo stesso tempo, e lo ribadisco senza il timore di scadere in una sterile retorica, proviamo a riscoprire il valore dell’arte. È molto semplice, dopotutto: mentre i video brevi offrono gratificazioni immediate e superficiali, l’arte crea un’esperienza di immersione, riflessione e connessione profonda. Non stiamo parlando di un contrasto meramente estetico, ma anche – e soprattutto – neuropsicologico. L’arte richiede al nostro cervello di rallentare, contemplare, concentrarsi. Tutta “roba” che il consumo compulsivo di contenuti digitali, come abbiamo visto, tende a reprimere. Durante la contemplazione di un’opera d’arte, al contrario, il nostro cervello attiva un processo (molto) complesso che coinvolge le aree responsabili dell’attenzione sostenuta, della memoria e della comprensione simbolica, come la corteccia prefrontale e il giro cingolato anteriore.
Si tratta di un “allenamento” mentale che richiede senza dubbio uno sforzo iniziale, il quale però ci ripaga con una sensazione di soddisfazione e completezza impossibili da ottenere attraverso un consumo passivo. È simile a ciò che si manifesta durante la meditazione o un’intensa attività fisica, tutte azioni in grado di ristabilire un equilibrio neurochimico, ridurre lo stress e migliorare il benessere generale. E questo parallelo con l’esercizio fisico diventa iper-evidente nella soddisfazione post-contemplazione. Proprio come una corsa impegnativa lascia il corpo stanco ma rivitalizzato, il confronto con un’opera d’arte può inizialmente sembrare cognitivamente “costoso”. Tuttavia, dedicare tempo all’arte ci permette di accedere a un livello più profondo di contemplazione e apprezzamento – sia sul piano intellettuale che su quello puramente emotivo –, generando un senso di realizzazione che si radica a lungo nella mente.
Dobbiamo rallentare, in definitiva. Sottrarre, eliminare il superfluo. Ridurre al minimo il “rumore” digitale e riappropriarci di piccoli interstizi di silenzio e contemplazione. Più facile a dirsi che a farsi, me ne rendo conto. Però voglio tornare ancora una volta sul concetto espresso poco fa: i contenuti digitali, quelli veramente di valore, dovrebbero invitarci a trovare del tempo per approfondire, contemplare, riflettere. Anzi, riformulo: “trovare” del tempo è un termine profondamente sbagliato. Il tempo lo abbiamo già – malgrado viviamo nella costante illusione di non possederne affatto –, semplicemente lo buttiamo via. Provate ad aprire Instagram e controllare il tempo di utilizzo giornaliero dell’applicazione: ci sono tutti i dati, giorno per giorno, di norma dell’ultima settimana. Per me è una sorpresa, ogni volta, scoprire quanti minuti – quante ore, talvolta – spendo sulla piattaforma. Eccolo il Brain Rot. E non voglio fare, lo ripeto, quello puro e giusto in un mondo malato. Chiunque usa i social, e sui social c’è tanta, tantissima roba interessante: io stesso (come qualunque altro contributor di Spaghetti Boost, per estensione) spero di creare contenuti di valore. Di nuovo, la soluzione è ridurre al minimo il rumore di fondo. Per non rimanere assordati. E, soprattutto, con il cervello “in marcescenza”.
Creativo, docente ed esperto di cultura visiva, Alessandro Carnevale lavora in TV da diversi anni e ha esposto le sue opere in tutto il mondo. Nel 2020, la Business School de Il Sole 24 Ore lo ha inserito tra i cinque migliori content creator italiani in campo artistico: sui social media si occupa di divulgazione culturale, coprendo un ampio spettro di discipline, tra cui la psicologia della percezione, la semiotica visiva, la filosofia estetica e l'arte contemporanea. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, pubblicato saggi e scritto una serie di graphic novel insieme al fisico teorico Davide De Biasio; è direttore artistico di un museo all'aperto. Oggi, come consulente, lavora nel mondo della comunicazione, della formazione e dell'educazione.



