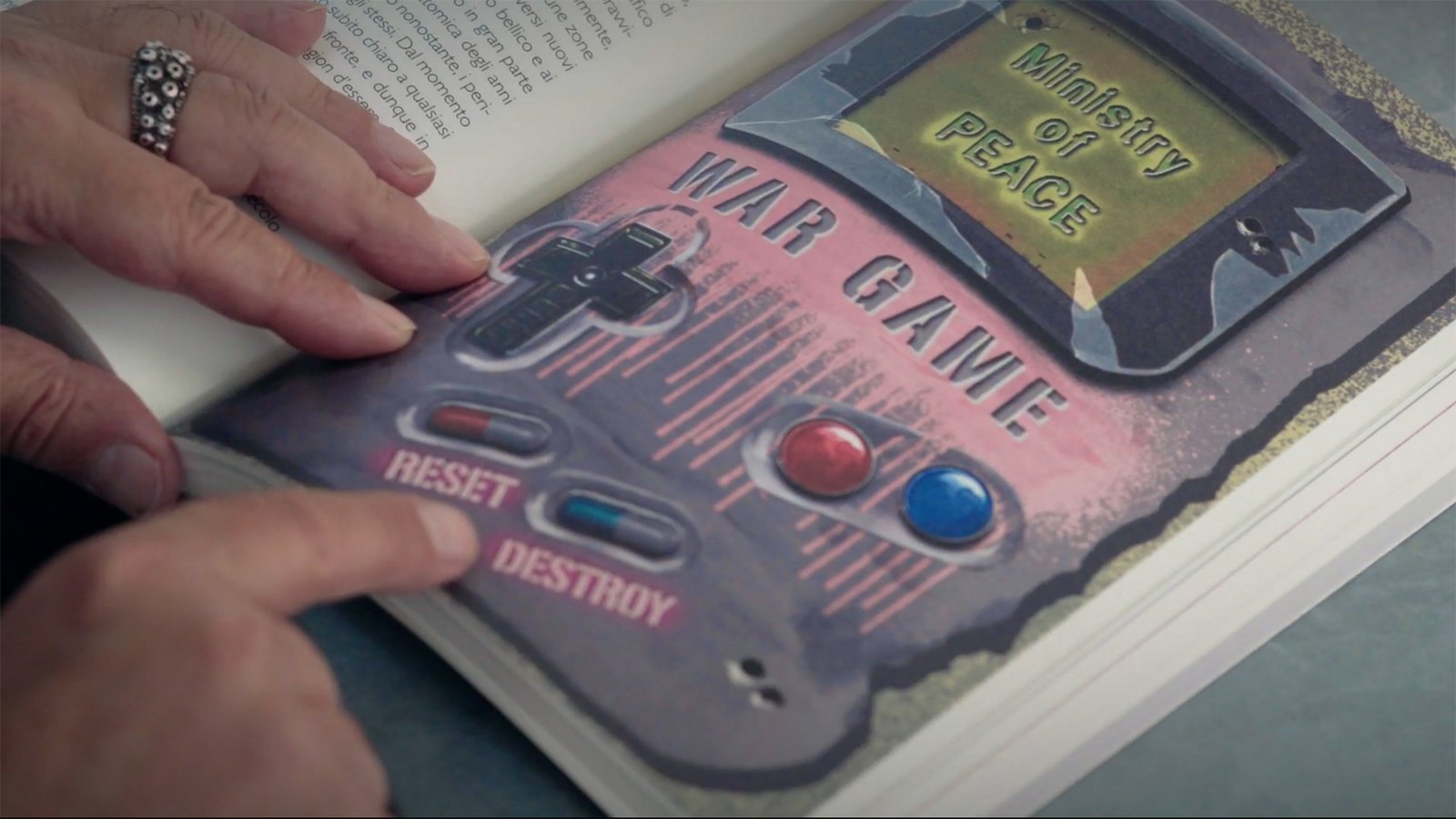Il respiro della natura negli spazi di cura: dialogo tra Biofilia, Design e Healing Gardens
Un ospedale in un giardino e un giardino in un ospedale.
Questa mattina, mentre percorrevo la strada verso la biblioteca dove abitualmente studio e lavoro, il mio sguardo è stato catturato da una coppia di scoiattoli nel giardino di fronte a casa. Saltavano, correvano, si arrampicavano sugli alberi con un’energia contagiosa. Spontaneamente ho sorriso e mi sono resa conto di come quell’ incontro casuale, breve ma intenso, avesse già migliorato la mia giornata.
Da questa immagine semplice, ma profondamente evocativa, nasce una riflessione: immaginate un ospedale in cui il verde delle piante si mescola al bianco delle corsie, dove il canto degli uccelli si sente oltre le finestre e dove pazienti, medici e cittadini condividono lo stesso giardino. Non è un’utopia. Negli ultimi anni, l’architettura ospedaliera ha iniziato a riabbracciare il concetto di biofilia, trasformando i luoghi di cura in veri e propri spazi di vita, dove la natura diventa parte integrante del percorso terapeutico e del benessere collettivo.
Questa esigenza si è ampliata in modo significativo dopo l'emergenza legata al Covid-19, un periodo che ha spinto a riflettere sull'importanza della natura come fonte di benessere. Ne è nata una tendenza sempre più marcata verso il ritorno alla connessione con il mondo naturale, sia negli spazi privati che in quelli pubblici.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una panoramica terminologica e mappare casi studio internazionali mettendo a confronto diverse culture e presentando dati sull’impatto che queste strategie hanno sul nostro benessere psico-fisico. Si intende inoltre evidenziare come la nuova visione dell’ospedale si stia sempre più avvicinando a una struttura integrata nel tessuto urbano, non più un luogo isolato riservato esclusivamente ai pazienti, ma spazio aperto e accessibile alla comunità.
Di seguito presentiamo un diagramma che facilita la comprensione del percorso terminologico che esploreremo, illustrando la connessione tra biofilia, design biofilico e healing gardens. Questo schema aiuterà a visualizzare in modo chiaro come questi concetti si interrelazionano e si applicano nel contesto degli spazi di cura.
 Mappa concettuale terminologica
Mappa concettuale terminologica
Il concetto di biofilia rappresenta il legame innato tra l’essere umano e la natura, un’affinità evolutiva che favorisce il benessere psicofisico. Introdotto nel 1984 dal biologo Edward O. Wilson nel suo libro Biophilia, questo termine evidenzia come gli esseri umani siano naturalmente predisposti a concentrarsi sulla vita e sui processi vitali, stabilendo connessioni biologiche con il mondo naturale. Wilson suggerisce che il nostro rapporto con la natura non è solo un piacere estetico, ma una vera e propria necessità biologica, fondamentale per il nostro equilibrio mentale e fisico. Numerosi studi, tra cui quello di Roger Ulrich, hanno dimostrato che la presenza di elementi naturali negli ambienti ospedalieri favorisce il recupero dei pazienti, riducendo il bisogno di analgesici e migliorando il benessere generale.
La biofilia, tuttavia, non è un fenomeno recente. Già nel XIX secolo, con l'espansione urbana e l’aumento delle problematiche sanitarie, gli ambienti naturali erano considerati strumenti di guarigione. Parchi come il Central Park di New York venivano visti come spazi vitali in grado di contrastare lo stress e promuovere la salute, un concetto che si sta evolvendo sempre più nei contesti urbani odierni.
Oggi l’applicazione del concetto di biofilia tramite il design biofilico si è consolidata come una prassi architettonica sempre più diffusa. Stephen Kellert, uno dei maggiori studiosi sul tema, ha sviluppato una teoria che integra i principi della biofilia nell’architettura, proponendo l’uso di elementi e forme naturali – come vegetazione, acqua e luce naturale – all’interno dell’ambiente costruito, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi lo abita.
Il design biofilico va ben oltre l’inserimento di piante o elementi naturali negli spazi. Si tratta di un approccio progettuale che cerca di ricreare l’esperienza della natura anche all’interno degli ambienti chiusi, con l’obiettivo di ridurre lo stress e promuovere il benessere psicologico e fisico. A tal proposito, Roger Ulrich ha dimostrato con uno dei suoi studi più noti View Through a Window May Influence Recovery from Surgery pubblicato nel 1984 che i pazienti che avevano una vista su spazi verdi guariscono più rapidamente rispetto a coloro che non avevano accesso a tali vedute.
 Using rainforests designed by cra carlo ratti-associati and big opens in Singapore
Using rainforests designed by cra carlo ratti-associati and big opens in Singapore
Un’applicazione particolarmente significativa del design biofilico riguarda gli healing gardens, giardini terapeutici progettati per favorire la salute e il benessere. Come suggerito da Clare Cooper Marcus e Marni Barnes nel loro lavoro Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations del 1999, questi spazi verdi sono pensati per ridurre lo stress e favorire il rilassamento, non solo per i pazienti, ma anche per i familiari e gli operatori sanitari. Gli healing gardens comprendono giardini terapeutici, orticultura, giardini meditativi e di riabilitazione, tutti progettati per stimolare il benessere fisico e psicologico. I giardini terapeutici sono spazi verdi strutturati per promuovere la guarigione, mentre gli spazi dedicati all’orticultura offrono opportunità di interazione diretta con la natura attraverso la coltivazione di piante. Infine, i giardini meditativi e di riabilitazione sono ambienti pensati per favorire il rilassamento, la riflessione e il recupero fisico e mentale, contribuendo in modo tangibile al benessere complessivo di chi li vive.
Dopo aver esplorato i fondamenti teorici e consolidato una base solida di conoscenze, possiamo ora procedere a mappare alcuni casi studio internazionali di particolare rilievo.
 Mappa geografica dei casi studio
Mappa geografica dei casi studio
Nel panorama internazionale, sempre più strutture sanitarie adottano il design biofilico e soluzioni innovative per integrare la natura negli spazi di cura, migliorando il benessere dei pazienti e delle comunità.
Il Khoo Teck Puat Hospital di Singapore, inaugurato nel 2010, è nato con l’ambizione di ridefinire il concetto di ospedale integrando natura, comunità e sostenibilità. Situato nel cuore della città-stato, questo ospedale pubblico si è affermato come un esempio globale di design biofilico. I giardini pensili ospitano progetti di agricoltura urbana, promuovendo la sostenibilità e offrendo spazi rigenerativi per pazienti, visitatori e personale. Gli studenti del quartiere trovano nelle sale d’attesa un ambiente tranquillo per studiare, favorendo un senso di apertura e comunità. Un acquario interno contribuisce ulteriormente a creare un’atmosfera di calma e serenità, rendendo l’ospedale un luogo non solo di cura, ma anche di connessione, ispirazione e spazio collettivo.
L’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, fondato nel 1891 come struttura privata per la cura dei malati, è oggi uno dei principali poli ospedalieri lombardi e un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria integrata. Tra gli interventi più significativi si distingue il giardino terapeutico, uno spazio esterno progettato per ridurre lo stress e promuovere il rilassamento. Qui, pazienti e visitatori possono godere di un contatto diretto con la natura, trovando sollievo e armonia in un ambiente accogliente e rigenerante. Questo spazio ha avuto un ruolo fondamentale durante i difficili mesi della pandemia di COVID-19, come ricorda il Dottor Albano nel suo volume I giorni più bui. Inoltre, il giardino è stato arricchito da installazioni temporanee in memoria di chi è scomparso durante l’emergenza sanitaria.
Il Policlinico Gemelli di Roma, inaugurato nel 1964 come ospedale universitario, rappresenta una delle eccellenze sanitarie italiane e il principale polo di ricerca e cura della capitale. Nel contesto del progetto Exploring the therapeutic benefits of biophilic design in hospital settings, promosso dal Centro Studi ReLab, ha sviluppato un giardino terapeutico innovativo. Questo spazio porta la chemioterapia all’aperto, in un’area protetta che offre viste sulla natura circostante. Il giardino comprende percorsi sensoriali, fontane e aree per la meditazione, oltre a pareti di verde verticale e ampie vetrate che favoriscono un continuo contatto visivo con il verde. Questi elementi, insieme al design biofilico degli spazi interni, creano un’esperienza sensoriale completa, alleviando lo stress e promuovendo il benessere.
Anche in Europa, numerosi progetti dimostrano come il legame con la natura possa essere declinato in modi innovativi e terapeutici, creando ambienti che riducono lo stress e promuovono la guarigione.
L’Oslo University Hospital, nato nel 2009 dalla fusione di quattro ospedali storici della capitale norvegese, è il più grande ospedale del Paese e un centro leader per la ricerca. Tra le sue iniziative più innovative spiccano gli Outdoor Care Retreats, rifugi in legno immersi nella foresta a breve distanza dall’ospedale. Queste cabine, accessibili anche a letti ospedalieri, offrono un’oasi di pace dove i pazienti e le loro famiglie possono rilassarsi, godendo della tranquillità e del potere rigenerativo della natura. Questa soluzione dimostra come sia possibile coniugare le sfide climatiche nordiche con un’architettura progettata per il benessere.
 The Outdoor Care Retreat, Oslo University Hospital
The Outdoor Care Retreat, Oslo University Hospital
Tra i progetti che hanno trasformato gli ospedali in luoghi di supporto emotivo e comunitario spiccano i Maggie’s Centres, nati nel 1996 grazie alla visione di Maggie Keswick Jencks, una paziente oncologica che immaginò un luogo di accoglienza per chi affronta il cancro. Il centro di Oxford, situato nei pressi del Churchill Hospital, richiama l’atmosfera di una casa sull’albero, con ampie vedute sull’esterno e una luce naturale abbondante. Questi spazi offrono non solo supporto emotivo e pratico, ma promuovono il rilassamento e la gestione dello stress attraverso ambienti che ispirano calma e serenità, rispecchiando pienamente la missione originaria di Maggie.
 Maggie’s Centre, Oxford
Maggie’s Centre, Oxford
Questi esempi evidenziano come l’integrazione della natura negli spazi di cura non solo arricchisca l’esperienza dei pazienti, ma trasformi gli ambienti ospedalieri in luoghi capaci di promuovere il benessere dell’intera comunità. Ora, li analizzeremo più da vicino attraverso una rubrica comparativa.

Il confronto tra i casi di Singapore, Bergamo, Oslo, Roma e Oxford mette in luce come il design biofilico, pur basandosi su principi universali di connessione con la natura e promozione del benessere, trovi espressioni uniche, adattandosi ai diversi contesti geografici, culturali e sociali.
- Approccio al design biofilico: Singapore si distingue per la sua integrazione su vasta scala, abbracciando sostenibilità e biodiversità in modo olistico. Oxford pone l'accento sull’esperienza emotiva e sulla centralità umana, mentre Oslo adotta un approccio pragmatico, superando i limiti climatici. Bergamo si focalizza sull’inclusione e l’apertura verso la comunità, e Roma emerge per il suo approccio sperimentale e scientifico.
- Spazi verdi: Singapore eccelle per la varietà e accessibilità dei suoi spazi naturali, Oslo per la capacità di rispondere alle sfide climatiche, Bergamo per la vocazione alla condivisione, Oxford per il coinvolgimento sensoriale, mentre Roma è un progetto in evoluzione, che si arricchisce di percorsi innovativi.
- Ruolo nella comunità: Singapore e Bergamo instaurano un forte legame con la comunità locale, Oslo e Roma si concentrano sui bisogni di pazienti e personale sanitario, mentre Oxford offre un ambiente accogliente che rafforza la relazione tra ospedale e territorio.
- Adattamento geografico e climatico: Ogni progetto rispecchia il proprio contesto: il clima tropicale di Singapore, le fredde atmosfere nordiche di Oslo, il Mediterraneo di Roma e Bergamo, e l'ambiente temperato di Oxford.
- Filosofia progettuale: Singapore emerge come esempio globale di sostenibilità, Oxford eccelle nell’umanizzazione, Bergamo privilegia l’inclusività, Oslo garantisce accessibilità e connessione con il paesaggio, e Roma innova grazie a un solido legame tra ricerca e pratica.
Questi casi internazionali testimoniano la versatilità del design biofilico e la sua capacità di trasformare gli ospedali in luoghi che vanno oltre la funzione sanitaria, diventando spazi di guarigione, incontro e innovazione. Il Khoo Teck Puat Hospital di Singapore si pone come pioniere globale, integrando ospedale e città grazie a soluzioni che uniscono natura, comunità e sostenibilità. L’Humanitas Gavazzeni di Bergamo rappresenta un modello europeo di ospedale civico, dove il giardino terapeutico diventa un punto di incontro tra cura e comunità. L’Oslo University Hospital, con le sue cabine immerse nella natura, è un esempio nordico di resilienza climatica e di sguardo alla tradizione delle cabin, mentre il Policlinico Gemelli di Roma sperimenta nuove frontiere documentando scientificamente i benefici del design biofilico. Infine, il Maggie’s Center di Oxford si concentra sulla dimensione relazionale, creando spazi che offrono sostegno psicologico ed emotivo ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.
Questi esempi internazionali non solo dimostrano la versatilità del design biofilico nel rispondere a esigenze culturali, climatiche e sociali diverse, ma sottolineano anche come questa filosofia progettuale sia in grado di ridefinire il ruolo degli ospedali. Da spazi dedicati esclusivamente alla cura, gli ospedali si trasformano in luoghi vivi, aperti e integrati con la comunità, capaci di promuovere il benessere collettivo.
Ma quali sono, concretamente, gli effetti di queste scelte progettuali sulla salute dei pazienti, sul personale ospedaliero e sulla società? Per rispondere a questa domanda, è fondamentale analizzare i dati e le evidenze che dimostrano l’impatto misurabile del design biofilico, sia in termini di benefici clinici che di trasformazione sociale e culturale.
La seguente tabella sintetizza l’impatto del design biofilico, illustrando come le sue applicazioni abbiano portato a risultati concreti: dalla riduzione dello stress alla diminuzione del consumo di farmaci, dal miglioramento della qualità del sonno a una maggiore soddisfazione generale, senza dimenticare il risparmio economico e il potenziamento del ruolo sociale degli ospedali. Questo approccio innovativo non solo cura, ma trasforma, rendendo gli ospedali dei veri hub di guarigione, incontro e innovazione.

Arrivando alla conclusione del nostro percorso, la domanda che sorge spontanea è: è possibile replicare questo modello di design biofilico in altri ospedali del mondo? La risposta è sì, ma con alcune sfide e adattamenti da considerare.
Un esempio interessante di adattamento delle soluzioni biofiliche a contesti normativi differenti è il Greenhaven Project del Chelsea and Westminster Hospital nel Regno Unito, realizzato in collaborazione con il Khoo Teck Puat Hospital di Singapore. In Inghilterra, infatti, la legge non consente di portare fiori o piante negli ambienti ospedalieri, grazie a un design innovativo e collaborativo è stato possibile ripensare gli spazi attraverso soluzioni che rispettano le normative, come l’introduzione di giardini biofilici in materiali sintetici nelle sale d’attesa e nelle aree di terapia. L’obiettivo principale di questo progetto è ridurre l’ansia dei pazienti e migliorare il comfort degli spazi ospedalieri utilizzando luce naturale, vegetazione e design multisensoriale. Un altro esempio parallelo è lo Sky Garden, progettato nell’ambito dell’ampliamento dell’unità di terapia intensiva, uno spazio dedicato alle sedute psicologiche dei pazienti e un rifugio naturale per il personale sanitario.
Questi progetti evidenziano l’importanza di un approccio flessibile e internazionale, in cui la collaborazione tra ospedali e designer permette di superare le barriere culturali, legali e logistiche, adattando il concetto di biofilia alle specificità locali. Ad esempio, il Greenhaven, progettato dall'architetto e psicoterapeuta Jinny Blom, è pensato per essere un’oasi rigenerante per pazienti, famiglie e personale, includendo anche spazi innovativi come le EnergyPod, capsule dedicate al riposo del personale. Questa collaborazione dimostra che l’adozione del design biofilico non è solo una questione estetica, ma una vera e propria rivoluzione culturale, che rende gli ospedali luoghi più accoglienti e funzionali, dove la natura gioca un ruolo centrale nel promuovere il benessere.
 Andorra Women and Children Hospital, Healing Gardens, Shahnaz Healthcare Interiors
Andorra Women and Children Hospital, Healing Gardens, Shahnaz Healthcare Interiors
Guardando al futuro, la sfida sarà quella di espandere questo approccio a livello globale, facendo in modo che ogni ospedale diventi un luogo di cura che non solo risponde ai bisogni fisici dei pazienti, ma che contribuisce anche al loro benessere psicologico e sociale. In questo senso, il design biofilico non rappresenta solo una tendenza, ma una vera e propria strategia per rendere la sanità più umana, sostenibile e centrata sulle persone. Come afferma la psicologa e urbanista Clare Cooper Marcus: “Gli ospedali sono spazi di cura, ma devono essere anche luoghi che ci permettono di riconnetterci con la nostra umanità.”
In questo scenario, il design biofilico emerge come una delle chiavi fondamentali per ripensare e trasformare gli ospedali, non solo come centri di cura, ma come veri e propri spazi pubblici, rigeneranti e sostenibili, che promuovono il benessere di pazienti, familiari, personale e comunità.
Bibliografia:
Albano, G. (2020). I giorni più bui. Milano: Piemme.
Cooper Marcus, C., & Barnes, M. (1999). Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations: John Wiley & Sons Inc.
Etezadifar, S. (2020). The Role of Biophilia in Hospital Humanization: The Case Study of San Luigi Gonzaga University Hospital (Rel. Riccardo Pollo). Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Architettura Costruzione Città.
Frampton, S. B., Charmel, P. A., & Planetree. (Eds.). (2016). Putting patients first: Best practices in patient-centered care (2nd ed.), Jossey-Bass.
Humanitas Gavazzeni. (2021). Il coraggio e la memoria. Lupo & Burtscher.
Kellert, S. R. (2008). Dimensions, Elements, and Attributes of Biophilic Design.
Lee, M. (n.d.). Khoo Teck Puat Hospital. Singaporeinfopedia. Disponibile all’indirizzo: https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1865_2012-01-18.html.
Oberti, I., & Lecci, M. (n.d.). When the Green Enters the Buildings: The Beneficial Effects. Focus.
RMJM. (n.d.). Khoo Teck Puat Hospital. Disponibile all’indirizzo: https://rmjm.com/portfolio/khoo-teck-puat-hospital-singapore/.
Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224(4647), 420-421.
Valente, R., & Cooper Marcus, C. (2015). Giardini che guariscono: Processi progettuali e realizzazioni di ambienti benefici. Firenze: Firenze University Press.
Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press.
Yishun Health. (n.d.). A Healing Space. Disponibile all’indirizzo: https://issuu.com/yishunhealth/docs/ktph_a_healing_space.
Immagine di copertina: Grenenhaven, Chelsea and Westminster Hospital, Londra
È cultural designer e dottoranda in Medical Humanities e Welfare Polices. Il suo filo conduttore è la cura del benessere delle persone, che sia dietro un palco con Grato Cuore, Rosetum Jazzfestival, una cattedra alla Mohole School o una ricerca per ripensare la progettazione degli ambienti sanitari attraverso interventi artistici. Con Spaghetti Boost affronterà diversi temi sul binomio arte e santità in contesti internazionali e nazionali, proponendo come innovarlo concretamente.