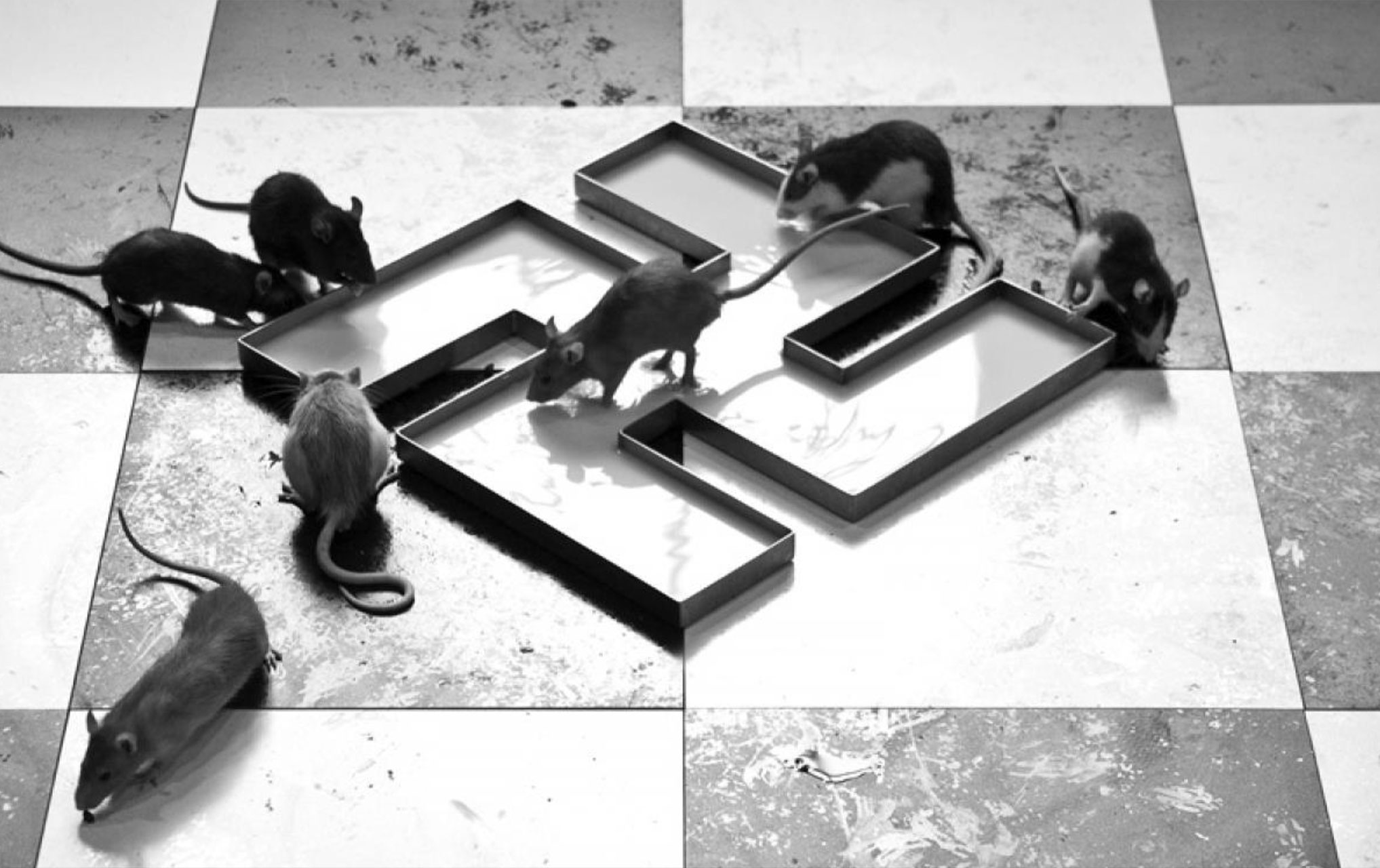L’arte è morta. Morta e sepolta.
 From Truisms (1977–79), 1982 Installation: Messages to the Public, Times Square, New York, 1982 © 2024 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY Photo: John Marchael
From Truisms (1977–79), 1982 Installation: Messages to the Public, Times Square, New York, 1982 © 2024 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY Photo: John Marchael
 Giovanni Anselmo, Invisibile
Giovanni Anselmo, Invisibile
 Damien Hirst, The Physical impossibility of Death in someone living
Damien Hirst, The Physical impossibility of Death in someone living
Ecco, pendiamo i Girasoli imbrattati: chi ha deciso d’inscrivere l’arte di Van Gogh fra i patrimoni dell’umanità? Noi. L’umanità stessa. E non è stato certo un processo facile. Vincent ha venduto un solo dipinto in tutta la sua vita. Per anni le sue opere sono state largamente disprezzate: i Girasoli sono sempre gli stessi, è il pubblico a essere cambiato, al netto del processo politico (nel senso più genuino del termine) che ha permesso all’opera di assorbire e contemporaneamente emanare quella stratificazione di significati affettivi, formali, qualitativi, mitici e simbolici che percepiamo violati dalla zuppa lanciata dagli attivisti. L’arte non è morta. Certamente, però, è agonizzante. Incide pochissimo nella vita delle persone. Le quali, forse per sfinimento, scelgono di non decidere – per citare un’ultima volta Dino Formaggio – che cosa chiamare arte. È possibile rovesciare il paradigma? Io credo di sì. L’arte deve invadere il presente, assediare l’esistenza, presidiare spazi ancora inesplorati. Deve tornare nella vita della gente. Perché slegata dalla vita, l’arte, è nel migliore dei casi nulla più di un semplice oggetto.
Immagine di copertina: Maurizio Cattelan, Comedian
Creativo, docente ed esperto di cultura visiva, Alessandro Carnevale lavora in TV da diversi anni e ha esposto le sue opere in tutto il mondo. Nel 2020, la Business School de Il Sole 24 Ore lo ha inserito tra i cinque migliori content creator italiani in campo artistico: sui social media si occupa di divulgazione culturale, coprendo un ampio spettro di discipline, tra cui la psicologia della percezione, la semiotica visiva, la filosofia estetica e l'arte contemporanea. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, pubblicato saggi e scritto una serie di graphic novel insieme al fisico teorico Davide De Biasio; è direttore artistico di un museo all'aperto. Oggi, come consulente, lavora nel mondo della comunicazione, della formazione e dell'educazione.